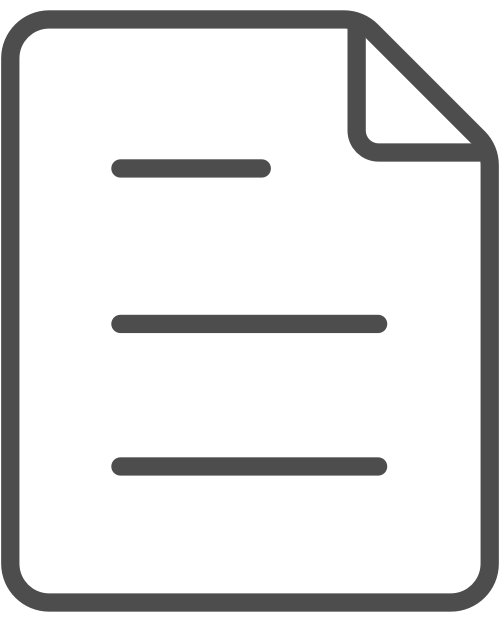Introduzione
Introduzione
In questo report:
Premessa: perché questo report
“In buone acque” è il report tematico che Hera pubblica ogni anno per integrare la propria rendicontazione di sostenibilità rispetto a uno dei temi più sentiti dai propri stakeholder: la qualità dell’acqua di rubinetto. È pubblicato insieme a "Sulle tracce dei rifiuti", il secondo report tematico di sostenibilità del Gruppo che ha l’obiettivo di tracciare la destinazione della raccolta differenziata e quantificare il tasso di riciclo della stessa.
L'obiettivo del report “In buone acque”, giunto alla sua diciasettesima edizione, è invece far conoscere tutte le attività che Hera svolge per garantire la qualità dell'acqua distribuita ai cittadini, rendicontando i dati sulla qualità e i processi messi in atto per assicurarla.
Portare l’acqua al rubinetto di casa dei cittadini è una attività complessa che richiede capacità di gestione, investimenti e costanti controlli. Per gestire l’intero servizio idrico integrato è necessario prelevare l’acqua dall’ambiente, e questo comporta spesso la necessità di sottoporla a trattamenti di potabilizzazione; l’acqua viene poi distribuita attraverso una rete di acquedotto che va tenuta in costante efficienza. Dopo il consumo, le acque reflue vengono raccolte nelle reti di fognatura e depurate negli impianti di depurazione. La gestione di queste attività comporta investimenti rilevanti sia per mantenere in esercizio le reti e gli impianti esistenti sia per ammodernarli e renderli più resilienti rispetto agli effetti del cambiamento climatico.
Dopo una introduzione sull’evoluzione della normativa europea in materia di acqua potabile e sulla quantificazione degli investimenti nel settore idrico, il report:
- descrive il ciclo idrico, dal prelievo dell’acqua fino alla sua restituzione all’ambiente;
- presenta le attività di controllo svolte da Hera e dalle aziende sanitarie locali;
- rendiconta i risultati delle analisi svolte da Hera, dalla società Romagna Acque – Società delle Fonti (responsabile dei processi di potabilizzazione dell’acqua distribuita e venduta da Hera nel territorio romagnolo) e dalle Aziende sanitarie locali;
- espone alcuni “paradossi” sull’acqua, i vantaggi dell’utilizzo dell’acqua di rubinetto rispetto a quella in bottiglia e i controlli svolti dal Gruppo sulla qualità dell’acqua oltre a quelli previsti dalla normativa.
L’evoluzione normativa europea e italiana sull’acqua potabile
La direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque potabili destinate al consumo umano ha modificato e superato la precedente direttiva 98/83/CE del 1998, ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n.18/2023 entrato in vigore il 21 marzo 2023, successivamente integrato dal D.Lgs n.102/2025 con disposizioni integrative e correttive ed entrato in vigore il 19 luglio 2025. Nel presente report relativo all’anno 2024, così come nel precedente report relativo all’anno 2023, si fa riferimento alla normativa approvata nel 2023, anticipando così gli obblighi normativi che entreranno in vigore da gennaio 2026 sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n.18/2023.
Nel Decreto, conformemente alla Direttiva europea, viene perseguito il principio di tutela della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, attraverso la revisione e l’aggiornamento degli standard qualitativi dell’acqua, ponendo dei limiti più severi e con l’introduzione di un approccio di gestione della sicurezza dell’acqua basato sul rischio. Viene peraltro prevista la ricerca di inquinanti che, seppure presenti in quantità minime, possono essere d’impatto sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo sanitario (bisfenolo A, acidi aloacetici, clorato, microcistine algali, PFAS, uranio), e viene introdotto il meccanismo delle watch list (liste di controllo) che consente l’ampliamento della lista di parametri da monitorare con sostanze o composti qualora destino preoccupazione presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica. In particolare, per i parametri citati, i gestori idro-potabili, le autorità sanitarie locali, le Province autonome e le Regioni devono adottare con tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro definiti per gli stessi.
Con la Decisione di esecuzione 2022/679 UE del 19 gennaio 2022 la Commissione europea ha inserito nell’elenco di controllo delle sostanze che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano due sostanze: 17 β-estradiolo e 4-N-nonilfenolo.
Il modello di riferimento nella gestione della sicurezza dell’acqua basato sul rischio (con carattere d’obbligo ma senza sanzioni) è stato introdotto dal DM 14 giugno 2017, mentre le tempistiche sono state definite successivamente con il D.Lgs. 18/2023. Questo modello impone ai gestori dei sistemi acquedottistici l’obbligo di sviluppare dei Piani di gestione della Sicurezza dell’Acqua (PSA) entro il 2029 per tutti i sistemi, conformemente ai principi introdotti dall’OMS nel 2004, in seguito trasposti dall’Istituto Superiore di Sanità nelle Linee guida 14/21 e aggiornate dalle Linee guida 22/33. La finalità è ridurre la probabilità di accadimento di non conformità, estendendo l’analisi dei rischi potenziali all’ambiente di captazione (di competenza delle Regioni e delle Autorità sanitarie), alle fonti idriche, al trattamento di potabilizzazione, fino alla fornitura idrica interna agli edifici (di competenza del gestore idrico interno).
Nel Decreto 18/2023, in coerenza con la Direttiva europea, è stata riservata anche un’attenzione particolare all’accesso all’acqua potabile e alla promozione della sua qualità presso i cittadini. Sulla base della nuova normativa viene infatti richiesto alle Regioni e alle Province autonome di adottare le misure necessarie per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l’accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati e garantendo la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale. A tale scopo, la nuova normativa elenca una serie di iniziative specifiche da attuare da parte delle Regioni e delle Province autonome.
Inoltre, il Decreto richiede alle Regioni e alle Province autonome di adottare azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua potabile di rubinetto, tra le quali si collocano l’incentivazione della sua messa a disposizione a titolo gratuito ai clienti di ristoranti e mense e l’attuazione di campagne di informazione per i cittadini circa la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.
Il report In buone acque, pubblicato ogni anno dal 2009, è la testimonianza della coerenza di Hera con gli obiettivi delle normative vigenti, nonché una buona prassi di rendicontazione trasparente volta ad accrescere la fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell’acqua di rubinetto.
I Piani di gestione della sicurezza dell’acqua (PSA)
Il D.Lgs. n.18/2023 (recepimento della direttiva europea 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) ha consolidato la metodologia di sviluppo dei PSA per l’individuazione delle attività di prevenzione e controllo finalizzate a garantire la migliore qualità delle acque potabili, già introdotta con il Decreto 14 giugno 2017 (recepimento della direttiva UE 2015/1787).
Si tratta di un sostanziale cambiamento di approccio ai fini della tutela della salute umana in tema di acque potabili che segna il passaggio da un regime di monitoraggio basato sul controllo retrospettivo di una serie di parametri analitici a una valutazione del rischio preventiva a più ampio raggio. Il nuovo approccio prevede il controllo di contaminanti emergenti (attualmente non oggetto di monitoraggio sistematico) e la verifica del grado di vulnerabilità dei sistemi idropotabili rispetto agli impatti diretti e indiretti indotti dai cambiamenti climatici.
Hera prevede da sempre piani di prevenzione e controllo strutturati che garantiscono ai propri utenti un’acqua buona da bere, nel rispetto dei requisiti normativi, e la pianificazione sistematica di controlli mirati su tutta la filiera di produzione dell’acqua potabile, dalle fonti di approvvigionamento alla distribuzione. A questo proposito, ogni anno viene stilato il “Piano di controllo analitico del servizio idrico integrato”, sostanzialmente in accordo con i criteri di valutazione dei rischi contenuti nel D.Lgs. n.18/2023 che fissa la scadenza del 2029 per la prima valutazione e gestione del rischio a carico dei gestori per tutti i sistemi idropotabili. Contestualmente, il Gruppo Hera sta sviluppando i PSA in tutti i territori serviti in ottemperanza all’obbligo normativo fissato per il 2029 (si veda la Rendicontazione di sostenibilità di Gruppo per approfondimenti).
L’aggiornamento degli standard qualitativi dell’acqua potabile (sia dal punto di vista chimico che microbiologico), l’introduzione di nuove soglie per alcuni contaminanti emergenti e la definizione dei requisiti per la valutazione dell’idoneità dei materiali destinati al contatto con l’acqua potabile sono elementi da includere nella definizione dei PSA, oltre a valutazioni specifiche di rischio connesse a fenomeni di cambiamento climatico.
Gli investimenti nel settore idrico
Dalla sua nascita (2002) il Gruppo Hera ha investito nel ciclo idrico in media 131 milioni di euro ogni anno: un flusso costante di investimenti garantito anche negli anni difficili di crisi industriale ed economica e di pandemia. Nel 2024 gli investimenti sono stati pari a 261,1 milioni di euro, di cui il 63% nell’acquedotto, il 16% nella fognatura e il 21% nella depurazione.
Includendo i lavori realizzati o finanziati dalle società nel territorio servito dal Gruppo nel 2024, sono stati effettuati complessivamente 298,6 milioni di euro di investimenti, 82 euro pro capite, il 14% in più rispetto ai 72 euro pro capite investiti in Italia nel 2024 (fonte: The European House - Ambrosetti, Libro bianco 2025 - Valore acqua per l’Italia).
Volendo confrontare la situazione italiana con il resto d’Europa, è possibile fare riferimento ai dati relativi all’ultimo quinquennio (fonte: The European House - Ambrosetti, Libro bianco 2025 - Valore acqua per l’Italia): in Italia sono stati investiti 62 euro per abitante, ben al di sotto rispetto alla media europea di 83 euro per abitante.
L’Italia rimane quindi nella metà inferiore della classifica europea per investimenti nel settore idrico per abitante: molto distante dai paesi più virtuosi come Norvegia, Danimarca, Estonia e Regno Unito (fonte: The European House - Ambrosetti, Libro bianco 2025 - Valore acqua per l’Italia). Gli investimenti nel territorio servito dal Gruppo Hera relativi al 2024 risultano invece allineati alla media europea.
Fonte: The European House - Ambrosetti, Libro bianco 2025 - Valore acqua per l’Italia. Media 2020-2024 o ultimo quinquennio disponibile
Uno dei motivi che spiega il livello ancora contenuto degli investimenti nel servizio idrico integrato in Italia rispetto agli altri paesi europei è riconducibile alla tariffa idrica. Con 2,4 euro per metro cubo a livello medio nazionale (dato 2023), l’Italia ha tariffe più basse del 50% rispetto alla media europea, pari a 3,6 euro per metro cubo (fonte: The European House - Ambrosetti, Libro bianco 2025 - Valore acqua per l’Italia).
Fonte: The European House - Ambrosetti, Libro bianco 2025 - Valore acqua per l’Italia. Dati 2023 o ultimo anno disponibile
Seleziona il tuo comune